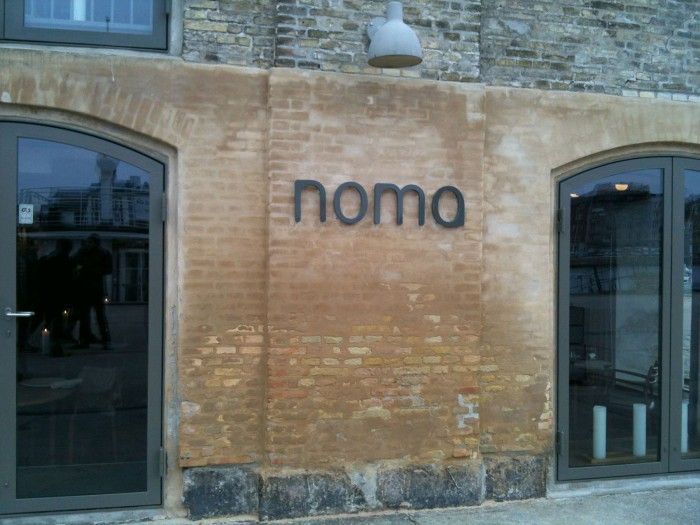
di Roberto Curti
Il gamberetto, sul suo letto di ghiaccio, muove appena le antenne. Il giovane cuoco, accento inglese purosangue, spiega che è stato pescato nelle profondità di un fiordo – dal nome, immagino, impronunciabile – restando intrappolato come tanti suoi simili nelle reti dei pescatori. Molti non ce l’hanno fatta, schiacciati dall’altro pescato. Quelli più fortunati, come lui, sono stati liberati con cura dalle maglie, immediatamente impacchettati e spediti fin lì, in modo da arrivare a destinazione ancora vivi.
Ora, se questa fosse una fiaba di Hans Christian Andersen – o, giusto per essere un pochino più attuali, un film della Pixar –, il gamberetto riconquisterebbe la libertà con un triplo carpiato. In fondo, il mare è a una dozzina di metri, lì, fuori dalla finestra, così vicino che ne puoi quasi sentire l’alito salmastro. Siccome invece siamo in un ristorante, ad attendere il morituro – condotto in tavola in un vasetto di vetro pieno fin quasi all’orlo di ghiaccio tritato – ci sono le fauci di un cliente un po’ perplesso ma tutto sommato incuriosito, e ben attento a seguire le istruzioni impartite. Il suddetto cliente apprende trattarsi di un esemplare dal sapore delicato e dolcissimo, da mangiarsi tutt’intero, guscio compreso, previo inzuppamento nel piattino dove lo attende una bruna salsina al beurre noisette.
Se questa fosse una fiaba di Andersen o un film della Pixar, tutto ciò avrebbe in fondo una sua morale, magari crudele. Mentre sgranocchio il piccolo crostaceo incatramato – e a dire il vero più di là che di qua: ma ho letto in giro resoconti in cui si raccomandava di dargli subito il morso di grazia per evitare che la bestiola scorrazzasse su e giù per il tubo digerente; che prima o poi salti fuori una leggenda metropolitana sul modello di quella, celeberrima, del bambino delle Big Babol? – l’unica conclusione che mi viene in mente, tra le solite scintille cinefile sparse (il polpo addentato vivo di Oldboy, Bud Spencer che ingoia un pesciolino appena preso all’amo in 4 mosche di velluto grigio), è quella di un sovrappiù. Gustativo, in primis.
Perché il burro finisce per seppellire, in tutti i sensi, il crostaceo. Riprovo con il secondo gamberetto – mia moglie, che da qualche minuto mi sta osservando come Wendy con Jack Torrance dopo aver scoperto che tutte le pagine del suo romanzo sono riempite con la stessa frase, non osa neppure sfiorare il corpicino – senza intingolo, e in effetti stavolta le papille reagiscono meglio: tenero, delicato, effettivamente dolcissimo.
La parabola del gamberetto e del burro – che ha fatto sbizzarrire blogger e giornalisti, incluso un interessante articolo sul blog del «Guardian» sull’eticità di mangiare un animale vivo, con riferimenti all’ikuzukuri e agli involtini di polpo vivo coreani – è a suo modo esemplare della mia esperienza al Noma, e forse vi si può rintracciare una chiave di lettura che vada al di là della cronaca spicciola. Per quella bastano i dati, che parlano da sé: primo ristorante al mondo nella classifica San Pellegrino, facilità di prenotazione pari a quella di scalare il Cerro Torre (il primo lunedì del mese, alle 9 del mattino, collegarsi al sito web del ristorante, quasi invariabilmente in tilt per via del numero di accessi, armarsi di pazienza, fare un fioretto alla Madonna e via di refresh non stop per riuscire a intrufolarsi in una finestrella libera; dimenticavo, si prenota di tre mesi in tre mesi).
E poi: ambiente superlusso fintopovero, un viavai di cuochi di provenienza cosmopolita che ti servono al tavolo (e se non altro evitando l’effetto-pappagallo degli ingredienti imparati a memoria e snocciolati a mo’ di scioglilingua) con brio e simpatia, un conto adeguato all’esperienza, una carta dei vini della serie guardare-ma-non-toccare. Insomma, il Noma è un brand accattivante, René Redzepi il gastropersonaggio per eccellenza dopo l’abbandono di Ferran Adrià, e l’idea di un’alta cucina nordica che coniughi sperimentazione e materia prima locale, provocazioni e un certo qual poverismo – anzi, primitivismo: vedi il festival “Flemish Primitives” dove René è uno dei mattatori – si è rivelata vincente sotto tutti i fronti.
Però, però.
Perché servire il gamberetto e l’intingolo, se lo stesso René dichiara di preferirli al naturale? Per indorare la pillola, e fare sì che l’esperienza risulti digeribile ai più? O al contrario per sottolineare lo stacco tra materia prima dura e pura e il sovrappiù offerto dalla cucina, ammettendo implicitamente che il senso della proposta non sta nell’oggetto ma nell’atto (ti siedi alla mia tavola pregustando leccornie indicibili e io ti porto un animale crudo, e non mi scomodo neppure ad ammazzarlo, ma te lo servo così com’è)? Sovrappiù, si diceva: anche concettuale. In questo, alcune proposte di Redzepi mi hanno ricordato i film del connazionale von Trier: trasgressioni hard e bellurie da videoinstallazione (che qualcuno prende per raffinatezza visiva, ma questo è un altro discorso), provocazione calcolata e alibi estetico/artistico. Qui comunque l’épater è all’acqua di rose, ma coglie nel segno: sentire per credere i gridolini/risolini soffocati agli altri tavoli all’arrivo del vasetto con ghiaccio e gamberetto.
Il dualismo materia prima/salsina ricorre spesso nella parata di finger food che aprono le ostilità. Dove si coglie la voglia di stupire, prendere in contropiede, giocarsi le carte più clamorose, facendo sfoggio di tecnica (gamberetto a parte, ça va sans dire), ironia e faccia tosta. Ma comunque con un occhio al commercio: perché va bene scherzare, va bene provocare, ma chi paga il conto deve pur godere di papille. E allora ecco le salsine a parte. La prima, una deliziosa crème fraîche, accompagna il primo snack a sorpresa: dopo averci accolto, spiegato la filosofia del ristorante, annunciato che quella che stiamo per intraprendere è un’esperienza particolare e unica, e illustrato per sommi capi l’andamento del percorso gustativo (una dozzina di stuzzichini iniziali da mangiare a mani nude, quindi il percorso salato, infine la chiusura dolce) il cuoco/cameriere spinge in mezzo alla tavola un vaso che lì per lì sembrava parte dell’apparecchiatura, e con un sorriso sornione ci invita ad estrarre due dei rametti che lo compongono (gli unici che si sfilano agevolmente dalla composizione floreale: «Se fa resistenza, desistete, è il rametto sbagliato»). Trattasi di focaccia al malto ricoperta di polvere di ginepro, da sgranocchiare intinta nella suddetta panna acida.
La stessa accoglierà il boccone successivo: una tempura di muschio (pardon: Cladonia arbuscula, lichene delle renne) ricoperta da una spolverata di polvere di porcini. Friabile ed eterea.
Sa di muschio fritto e crème fraîche. Il crostino gobbo lì accanto, fatto di pelle croccante di maiale ricoperto da una pellicola di ribes, è uno sfoggio di tecnica mica male, e propone uno dei temi gustativi predominanti del pranzo, l’accostamento tra l’acido dei frutti di bosco e l’affumicato.
Le cozze sono un altro divertimento scenografico: la parte superiore del guscio si toglie, quella inferiore (creata con nero di seppia, acqua e farina) si mangia. E anche qui torna l’idea del camuffamento ludico: i due bivalvi sono presentati in un piatto ricoperto di gusci vuoti, dove a prima vista si confondono.
Dentro una scatola di biscotti in latta, ecco due biscottini salati di formaggio e lardo ricoperti da una montagnola di rucola e dal lieve sentore affumicato; preludono al gran momento del gamberetto.
Il boccone successivo è uno dei classici del Noma: un sandwich di pelle di pollo e segale farcito di uova di lompo e crema al formaggio. Redzepi reinventa lo smørrebrød, il tipico snack danese, un panino aperto di pane di segale da farcire a piacere (con insalata di pollo o uova di pesce, ad esempio), declinando i medesimi ingredienti in forme, posizioni e consistenze nuove: impeccabile.
Ecco un altro accoppiamento salsesco: carota disidratata ed essiccata da intingersi in una salsina all’acetosa. Anche la mamma, quando da bambino schifavo le carote, piazzava strategicamente un po’ di maionese a lato; qui però la consistenza della verdura è sgradevolmente gommosa, simile a una stecca di liquirizia.
Tutt’altra faccenda l’uovo di porcellana che, aperto, sprigiona un aroma pungente e svela due uova di quaglia sottaceto, cotte in camicia e affumicate, da mangiarsi in un sol boccone (il tuorlo è ancora liquido). Golosissime.
Altro scherzone: un vaso di fiori dove sono piantate carote e rapanelli, da sgranocchiare intingendole nella “terra” del vaso, uno strato di malto, grumi di farina di nocciole e birra, scaldato ed essiccato, sotto cui si cela una crema di yogurt di pecora al dragoncello. Qui un cucchiaio sarebbe stato utile, per evitare di leccarsi le dita in pubblico: ma forse a René piace vederci scavare.
Ancora un toast: erbe, emulsione di uova di merluzzo affumicate, aceto, ricoperto da una crosta traslucida di “pelle d’anatra” (ottenuta scremando il brodo dell’animale e facedolo asciugare). Nulla da obiettare al gusto, tanto di cappello alla tecnica, anche se non si può fare a meno di notare una certa ripetitività di forme, consistenze e sensazioni, con l’affumicatura a fare da fil rouge tra quasi tutti i piatti.
A concludere gli snack, arriva questa cosa inquietante: un pesciolino (si tratta del muikku o coregone bianco, manco a dirsi affumicato) infilato, o così pare, in una palla ricoperta di zucchero a velo: altra rivisitazione di un piatto tipico locale, gli Æbleskiver, sorta di pancake sferici cucinati nel periodo prenatalizio, che Redzepi sposta dal terreno del dolce a quello del salato: e al posto della mela richiesta dalla ricetta tradizionale, all’interno troviamo pezzettini di cetriolo sottaceto. Buono, lo sarebbe di più se l’interno non avesse una temperatura quasi pari alla famigerata crocchetta di patate fantozziana.
Conclusa la parte ludica, e introdotto da una calda pagnotta racchiusa in un involucro di feltro e da accompagnare con burro salato di capra e lardo, inizia il pranzo vero e proprio. Dove si nota come l’introduzione di note acide/amare sia comunque bilanciata dal frequente impiego di salsine, pentolini e riduzioni assortite per completare il piatto a tavola (sei portate su dieci), con l’apporto di panna e siero di latte a dare un tocco di ruffianeria qua e là.
L’inizio – sedano rapa, bacche di prugnolo verdi, ribes bianco e pino – punta deciso sull’acido: piatto tutto di testa, bandierina sulla carta geografica a ricordarti dove sei, sgrassando il palato e preparandolo per quello che verrà.
Seguono tre portate di mare. Al di là dell’interessante consistenza dell’uovo, il granciporro atlantico, tuorlo d’uovo marinato e erbe, completato da un brodino del granchio stesso, non è una di quelle epifanie che ti cambiano la vita.
Più interessanti le capesante – congelate e tagliate in sfoglie sottilissime poi essiccate – appoggiate su noci di faggio, grano biodinamico e crescione, e su salsina al nero di seppia. L’idea è forse migliore del risultato, in un gioco di consistenze dove il mollusco, ridotto a chip, fa quasi da comprimario – e a dirla tutta anche un po’ sacrificato.
È la volta dell’ostrica del Limfjord – grossa, succosa, cotta al vapore per pochi minuti, scaloppata in tre parti e servita con uva spina, lattuga di mare, cipolla e latticello, a esaltare la componente acidula del piatto. Eccellente.
Il cavolo – prima cotto poi gratinato, servito con due intingoli, una cucchiaiata di panna al rafano e una salsa verde all’olio essenziale di abete rosso e siero di latte – non è esattamente bello a vedersi, come del resto buona parte delle altre portate. D’accordo, ancora la foresta, e s’è capito: ma data la concentrazione gustativa della salsa, la presenza degli aghi di pino (no, non li ho mangiati) è ancora un sovrappiù. Il risultato però è gustoso: un intelligente piatto vegetariano.
Dimenticate la schiuma, dimenticate gli sbaffi verdi concentrici tipo Last al limone: il luccioperca, grigliato e avvolto in una foglia di cavolo cotta al vapore, con foglioline di aneto e ancora due salse (una alla verbena e un’emulsione schiumosa ottenuta dalle lische, con presenza tangibile di vino bianco), è finalmente un grande piatto.
Verdure sottaceto e midollo: «il nostro minestrone» scherza il cuoco. Per una volta bello a vedersi, e perdipiù squisito: tra i cilindri multicolori (ogni verdura è stata marinata in un aceto differente, viene puntualizzato) fanno capolino dischi di midollo, e a completare il tutto viene versato un ruffiano bouillon ottenuto con ossa di maiale e beurre noisette. Il piatto migliore della cena.
Preceduta dall’apparizione di un inquietante pugnale che pare un’arma di scena di un film sui vichinghi (aridaje con il primitivismo chic), è la volta dell’anatra selvatica con barbabietole, foglie di faggio, malto. Il gioco di ricreare l’habitat dell’animale in chiave edibile è simpatico, l’effetto al gusto un po’ deludente – la frollatura non è forse impeccabile, e la cottura farebbe storcere il naso a molti – anche se sono divertenti le finte bacche, sorta di pop corn di lievito cotto al forno ad altissima temperatura e ricoperto di polvere di ginepro.
Infine, i dessert. Carote, olivello spinoso, yogurt di capra: un dolce-non-dolce piuttosto interessante, con le carote in diverse consistenze – una sorta di meringa ricoperta da fettine fresche e altre, più scure, semiessiccate.
Brunost e bacche di prugnolo, in una riduzione di queste ultime: il tipico formaggio norvegese fatto col siero del latte abbinato, come si usa da queste parti a colazione, da frutti di bosco, in un’altra rivisitazione di un piatto della tradizione.
A concludere la maratona (peraltro al di sotto delle quattro ore minacciate, complice un certo affanno nell’accumulo iniziale di sfizioserie), flødebolle allo yogurt, chips di patata ricoperte di cioccolato con finocchietto e caramella di midollo, servita in un involto di carta da macellaio. Th-th-th-that’s all, folks!
In conclusione: un’esperienza molto divertente, una cucina più godibile del preventivato, che intriga il palato e titilla il cervello ma non sempre – o comunque non nel mio caso – conquista il cuore. Alla fine, lasciando da parte elucubrazioni, descrizioni, divagazioni e impressioni varie, il tutto si riduce a due sole domande: Ti è piaciuto? Sì, però… Ci torneresti? No, ma…
Strandgade 93
1401 Copenaghen
Tel: + 45 3296 – 3297
www.noma.dk
Chiuso: domenica e lunedì
Dai un'occhiata anche a:
- Filaga, una fetta di Sicilia nel Chelsea Market di NYC
- Agli Amici Dopolavoro Venezia, lo stile Scarello in Laguna
- Max Stark: autentica cucina renana a Colonia
- Starfish Atlantic Grill di Tenerife, dove il pescato fresco è protagonista
- Trattorie & Osterie di Milano e Lombardia, locali della nostalgia e della gioia
- La cucina di capogiro al 7pines Sardinia e Spazio a Baja Sardinia
- Restaurant Le Prieuré a Megeve, il bistrot di Emanuel Renaut
- Bacari, osterie e ristoranti a Venezia. Dove mangiare durante la mostra del cinema con un’autoctona cosmopolita. Edizione 2025, riveduta e aggiornata