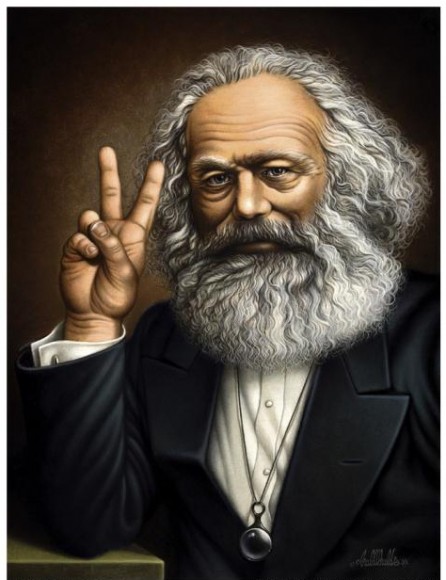
Sono molti gli appassionati, gli studiosi e i critici che non riescono a risolvere questo ossimoro: come mai l’Irpinia è uno dei territori enologici più interessanti d’Italia ed è al tempo stesso anche tra i più arretrati nel presentarsi all’esterno? Come mai esistono aziende splendide da visitare ma è difficile organizzare un percorso enoturistico se non a costo di molte ore e tanta fatica?
Il Consorzio ha praticamente levato mano (come si dice a Napoli) e l’Anteprima Taurasi si è svolta solo per iniziativa privata a cui il Comune di Taurasi ha fatto pagare il Castello perché la manifestazione gli ha occupato le sale ogni giorno affollate di migliaia visitatori e appassionati che arrivano con i pullman dopo la mitica inaugurazione elettorale tenuta con Bassolino e Nappi nel dicembre 2009 che costò centomila euro di vecchie lire:-)
C’è stato qualche tentativo di interpretazione, come il gustoso articolo degli amici Alessandro Franceschini e Maurizio Paolillo su Porthos qualche tempo fa che ha avuto il pregio di essere divertente, di aprire senza dubbio il dibattito, ma di non aver centrato sino in fondo la questione inserendo anzi elementi che francamente c’entrano molto poco con l’Irpinia, tipo la delinquenza organizzata che, come ben sanno coloro che si occupano di queste cose, non è determinante oltre la Valle di Lauro e Baiano.
Nonostante le apparenze, sono molto metodico e sono dunque tornato ai vecchi sistemi di un tempo, quando negli anni ’70 si faceva politica di territorio nelle scuole e nei quartieri, convinto appunto che è l’essere sociale a determinare la coscienza; anche se questo assunto marxiano non deve essere preso sempre alla lettera altrimenti non ci spiegheremmo Che Guevara. Ma questa è una considerazione di maturità postuma.
Resta il dato di fondo, molto vero, che la maggior parte di noi la pensa a seconda di come arriva il piatto a tavola.
La disumana politica della Lega ne è un esempio.
Se per esempio siamo a carico delle famiglie e campiamo sostanzialmente sui redditi dei nostri genitori perché la società non offre più spunti sicuri di lungo periodo, saremo portati al facile ipercriticismo, la tentazione di rovesciare il tavolo sarà molto forte, perché, male che vada, avremo sempre un piatto da mangiare e un letto su cui dormire. E, poi si sa, se si strilla un po’ i genitori finiscono per darti sempre ragione. Allo stesso modo, se il nostro futuro non dipende esclusivamente dalle bottiglie vendute, possiamo concederci molti lussi, come tenere il punto, o magari non fare nulla aspettando che siano altri a muoversi.
Al di là di questo sociologismo da sala di attesa del dentista, purtroppo però molto fuso alla realtà quotidiana, vediamo allora la situazione irpina.
Dunque ho rispolverato le mie guide e incrociato i dati con l’ultima pubblicazione della Camera di Commercio di Avellino vedendo effettivamente, azienda per azienda, come stanno le cose.
Oltre le cifre iscritte alla Camera di commercio, sono 140 circa le aziende effettivamente operanti. Di queste, quattro (Mastroberardino, Terredora, Feudi e Montesole), superano il milione di bottiglie ma solo Feudi va oltre i due mentre quattro (Di Meo, D’Antiche Terre, Struzziero, Vinosia), sono sulle 500.00 bottiglie. Il panorama dei produttori professionisti è completato dalla presenza di tre aziende napoletane (Cantine Astroni, Grotta del Sole, De Falco), una casertana (Villa Matilde), una abruzzese (Vesevo di Farnese), una con radici pugliesi (San Paolo).
In complesso, comprese le aziende che abbiamo citato, sono circa 35 le cantine professionali, cioé che vivono esclusivamente grazie al reddito prodotto in agricoltura.Tutte le altre sono composte da persone che fanno un altro mestiere (ingegnere, operaio, avvocato, asfaltatore, allevatore, geometra) e che avevano vissuto in precedenza la viticoltura solo come reddito integrativo. Si tratta cioé di figli o nipoti di contadini che hanno studiato, si sono urbanizzati e hanno ricevuto un pezzetto di terra in eredità. In soldoni, vendevano l’uva alla Mastroberardino sino al 1990, quando le aziende imbottigliatrici erano appena dieci. Successivamente anche ai Feudi. Solo un caso nasce come investimento da rimesse di emigrazione, due come articolazione della propria attività di enologi o studioso, tre da imprenditori di altro ramo che hanno o valorizzato o comprato vigneti nel proprio paese di origine organizzando però la cantina come azienda autonoma.
Delle aziende di vera origine contadina di cui tanto favoleggia chi ancora è fermo a Ernesto De Martino, appena due sono aperte dopo il 2004 (Il Cancelliere e Boccella), una ha venduto (Alessandro Caggiano) dopo aver declassato per anni il prodotto per piazzarlo a prezzo più basso. Stop.
Contadini irpini non ne esistono più da almeno trent’anni, almeno quelli che abbiamo visto combattere i piemontesi nei film di Amedeo Nazzari. O sono emigrati o sono stati assunti negli enti pubblici, oppure hanno studiato e hanno abbracciato le professioni liberali. Quelli che non sapevano proprio fare nulla sono diventati amministratori dei loro comuni
Altro che viticoltura della sopravvivenza, questa è agricoltura di risulta professionale e di abbondanza calorica. E se ne parliamo e ci appassioniamo è perché ci sono i grandi e piccoli marchi commerciali affermati grazie alla qualità dei loro prodotti.
In questa prospettiva è sorto il fenomeno dei fornitori di uve che si sono trasformati in produttori. Quelli che hanno fatto questo passo all’inizio degli anni ’90 si sono ritrovati un marchio grazie al positivo fenomeno di riscoperta della viticoltura italiana: Molettieri e Caggiano per l’Aglianico, Benito Ferrara per il Greco, Clelia Romano e Guido Marsella per il Fiano. Tutti sono di prima generazione e alle prese con il ricambio che per fortuna sta riuscendo. Era esigenza delle guide e del giornalismo scoprire nuove cose e il meccanismo ha funzionato bene per tutti. Anche perché si è lavorato bene.
Come si vede, dunque, siamo in presenza di un tessuto produttivo sulla carta numeroso ma di fatto molto esiguo e totalmente privo di auto-coscienza collettiva, oltre il 75% delle aziende iscritte produce meno di centomila bottiglie.
Solo Mastroberardino/Terredora e Struzziero hanno vissuto la crisi della fillossera e la guerra. Solo dieci aziende erano piedi prima del terremoto del 1980. Non 1880!
Cosa comporta questa analisi della base produttiva della viticoltura irpina?
Primo: lo scarso, scarsissimo peso politico e sociale. Qualsiasi persona sana di mente avrebbe puntato sulla viticoltura dopo il sisma. Il ceto politico dell’epoca, dominato dai demitiani e dai comunisti, non vedeva invece nessuna prospettiva nel lavoro dei campi e ha individuato nella costruzione di grandi nuclei industriali l’unica possibilità di riequilibrare il peso delle aree interne rispetto alla costa. Esattamente l’opposto di cui si aveva bisogno. Esattamente però quello che chiedevano gli elettori: non vogliamo più coltivare la terra, meglio fare i portieri in città e poi coltivare un po’ di insalata biologica nel tempo libero per non prendere il cancro.
Secondo, come i bamboccioni che ho citato prima, alla fine almeno l’80% delle persone impegnate a produrre vino in Irpinia potrebbero sopravvivere tranquillamente e senza grandi sacrifici se una legge proibisse improvvisamente la vendita pubblica di alcol.
Qualcuno perderebbe un po’ di soldi, ma alla fine non sarebbe un dramma.
Le grandi aziende, e quelle venute da fuori, sono ben consapevoli di questa situazione di debolezza del resto della filiera. Non sono contrarie alla esistenza delle piccole, ma non le ritengono affidabili, non le prendono sul serio.
In effetti l’immagine che può rappresentare la situazione è un cono rovesciato: per questo le grandi cantine sanno bene che il loro futuro è affidato sostanzialmente alla possibilità di rafforzare il marchio aziendale più che il territorio in astratto.
Enzo Ercolino ha rappresentato questa filosofia senza se e senza ma.
In poche parole, credo che di fatto le aziende che superano le 500.000 bottiglie regalano molti visitatori e molti acquirenti al territorio, ma il sistema nel suo complesso non regala neanche una bottiglia alle grandi. Una che è una, no. E questo i produttori professionisti lo sanno benissimo.
Insomma, per dirla brutalmente, nessuno compra Feudi o Mastroberardino per provare un vino irpino. Ma esattamente il contrario. I milanesi hanno conosciuto la Falanghina grazie a Feudi, non i Feudi grazie alla Falanghina.
Prova provata un giro nei ristoranti italiani del centro nord che chiunque si interessi di queste cose dovrebbe fare abitualmente ogni anno, per capire che in carta ci sono solo i “grandi” e qualche “piccolo” (Marsella, Ferrara, Caggiano, Pietracupa, Molettieri, Vadiaperti, Picariello, Quintodecimo).
Nella maggioranza di ristoranti di fascia medio-alta nella lista dei rossi ci sono solo Taurasi Mastroberardino, Montevetrano, Terra di Lavoro e Vigna Camarato di Villa Matilde.
Una situazione angosciante?
Per nulla. Sarebbe strano se le cose stessero diversamente. Era angosciante per me trovare le bottiglie Santa Margherita nelle pizzerie di Napoli alla fine degli anni ’80. Questo sì che era deprimente.
Io sono abituato sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Infatti spesso confondo un coglione per una possibilità:-)
Da consumatore so di avere molte possibilità a buon prezzo, buone tipicità, molte sorprese, tanto entusiasmo e tanti giovani impegnati. Alla fine se un ingegnere invece di sputtanarsi i soldi a Capri o a troie valorizza la sua proprietà è un dato positivo per il territorio. E così è stato, in effetti.
Da giornalista però so che comunque questa situazione di sviluppo è affidata all’autogoverno del mercato: se l’export come pare riprende, ad un certo punto alcune aziende si porranno il problema di come crescere insieme.
Probabilmente si tratterà di prendere finalmente e serenamente atto del fatto che i grandi (anche se questa parola nel mondo globale fa un po’ sorridere) hanno degli interessi precisi comuni mentre le piccole aziende, quelle che vivono di reddito integrativo e non principale, ne hanno altri. E che se queste due esigenze, a mio giudizio (e a quello molto più autorevole del professore Eugenio Pomarici) niente affatto in contrapposizione bensì ad adiuvandum, ogni tanto si incrociano, sarà necessario che chi di dovere ne prenda atto.
Al momento, non esiste un numero di aziende irpine sufficiente a sostenere una manifestazione di promozione autofinanziata in grado di incidere positivamente sul loro fatturato e dare ristoro a chi questo lavoro di comunicazione di qualità vuole farlo. Per le “grandi” diventa una testimonianza di affetto del territorio, così come per le piccole che hanno il marchio consolidato, mentre per le altre non ha poi molta importanza andare oltre il loro giro di distribuzione.
E noi? Continueremo a raccontare e a incoraggiare chi vuole fare seriamente.
Questo è il nostro lavoro. Niente altro, semplicemente raccontare. I vini che ci piacciono, le vigne dei nostri sensi e le persone che amiamo.
E a incoraggiare.
Però vi diciamo anche: Giocagiò non va più in onda.
Dai un'occhiata anche a:
- Sonia Gioia: da giornalista gastronomica a “donna dei cani”
- Andrej Godina: Report ha ragione, il caffè italiano è in ritardo su trasparenza e cultura della filiera
- Ristorazione in crisi? No, non va tutto bene. Soprattutto nei piccoli centri
- Pizzeria blasonata? A cominciare dal formaggio Ahi ahi ahi….
- Le sei tendenze nel mondo pizza che vivremo nel 2025
- Roccaraso invasa? Lasciateci la frittata di maccheroni
- Fine dining in crisi? I cuochi hanno dimenticato i clienti, detto da un cuoco stellato
- Quattro cose che non si trovano più al ristorante